
Una cintura forestale periurbana per migliorare la qualità della vita in città
Non basta una coscienza ambientale. Non c’è cambiamento senza conoscenza e senza conoscenza non si fanno scelte coraggiose
Daniele Zavalloni, Geografo, Segretario associazione GUFI
- La necessità di acqua e aria pulite
Il Guardian, in un editoriale della caporedattrice Katerina Viner[1] pubblicato in autunno del 2019, ha dichiarato che il temine “cambiamento climatico” non ha la forza per descrivere la drammaticità del momento: di fatto il termine non chiarisce le conseguenze delle scelte che l’umanità ha fatto nel passato. È più chiaro parlare di “collasso climatico” che, di fatto, è già in atto da molti anni. Quello che stiamo subendo è il nuovo clima con il quale dobbiamo convivere e bisogna procedere, nel poco tempo rimasto, a una drastica riduzione delle emissioni dei gas serra e all’estrazione dall’atmosfera di quanto vi è stato immesso in eccesso rispetto alle capacità portanti del Pianeta. Concordiamo pienamente con la scelta del Guardian! Non sappiamo cosa possa riservarci l’imminente futuro; anche se i segnali sono evidenti e inequivocabili.
Ma di là di ogni cambiamento climatico, l’uomo, ognuno di noi, ha due necessità alle quali non può rinunciare perché sono vitali e irrinunciabili: il bisogno di aria pulita e di acqua pulita. Questi due beni, tuttavia, sono sempre meno disponibili per le nostre città.
Gli unici esseri viventi che possono produrre aria pulita e acqua pulita in grande quantità, oltre ad assorbire rapidamente anidride carbonica, sono i vegetali, e questa produzione si manifesta in quantità decrescente a seconda che si considerino gli alberi, gli arbusti e le piante erbacee.
Questa funzione viene svolta in modo preponderante da una copertura forestale adeguatamente strutturata, che si connota funzionalmente/strutturalmente come “ecosistema[2]”, senza nulla togliere al ruolo che svolgono le alberature stradali o agli alberi dei parchi urbani, anch’essi importanti, ma che non costituiscono un ecosistema.
L’ecosistema in quanto tale non ha bisogno di nessuna manutenzione. Solo un rimboschimento – ecosistema artificiale di natura forestale – nella fase iniziale di impianto può avere necessità di manutenzione, in particolare quando piantiamo gli alberi provenienti da vivaio. Prelevare piante nate in vivaio è una soluzione che di solito si adotta per accelerare i “tempi” di formazione di un ecosistema forestale, anche se molte volte è solo un’illusione; di fatto, se avessimo tempo di aspettare, il bosco arriverebbe da solo.
Sappiamo benissimo che il “tempo non lo possediamo” ma possiamo solo “vivere il tempo”, ed è per questa ragione che riteniamo sia importante raccogliere semi di specie forestali, per realizzare le fasce boscate periurbane, mentre “viviamo il tempo”.
Sono i parchi urbani che hanno necessità di “manutenzione” cioè di cura, di attenzione affinché possiamo frequentarli agevolmente, anche da parte persone con disabilità; alla stessa maniera, anche se per altre ragioni, hanno bisogno di attenzione ed eventualmente di manutenzione le alberature stradali, e soprattutto hanno bisogno di esperti che smettano di adottare la pratica della castrazione delle medesime gabellandola per potatura, pratica che è all’origine, in molti casi, della instabilità e della pericolosità delle piante.
Una città con un’adeguata dotazione di alberi beneficia di tutti i vantaggi che questi possono apportare, a cominciare dall’effetto tampone nei confronti della temperatura che durante l’estate può ridurre di 4 C° rispetto alle zone aperte mentre in inverno può innalzare in egual misura le temperature mitigando i rigori della stagione.
Ma è sulla qualità dell’aria e dell’acqua che si manifestano gli effetti più consistenti. L’aria è depurata delle particelle inquinanti che sono intrappolate e trattenute dalla superficie scabrosa o pelosa delle foglie e, in molti casi, assorbite dalle piante in cui il cosiddetto “scambio gassoso” con l’atmosfera è continuo; così come sono ininterrotti l’assorbimento di CO2 e la cessione di ossigeno.
L’acqua è depurata a livello di radici, sia direttamente a opera della componente microbica del suolo e simbionte – basti pensare alla fitodepurazione delle acque reflue – sia attraverso i processi evapotraspirativi. Ma gli alberi, con il suolo e con le comunità viventi in esso contenute, svolgono anche una fondamentale azione di regolazione del ciclo dell’acqua, regimandola quando è in eccesso, conservandola e, addirittura, rendendola disponibile quando scarseggia in presenza di eventi meteorici ridotti o nulli quali la pioggia o la neve.
Tra i servizi ecosistemici che gli alberi svolgono ci sono quelli che incidono sulla salute fisica e sulla salute psichica, e i cittadini dovrebbero fare proprio questo messaggio che è prima di tutto un messaggio culturale, leggendo con un occhio e un’attenzione diversa la presenza dell’albero in tutti i luoghi possibili, per il loro apporto alla qualità di vita della città.
Pertanto, è possibile dare una risposta concreta alla necessità/esigenza di acqua e aria pulita nelle nostre città attraverso la realizzazione di fasce boscate periurbane.
Nell’accezione comune, il bosco è collocato in montagna, che è ritenuto il luogo per eccellenza per ospitare questi ecosistemi, ed è quasi sempre lontano dalla città.
Culturalmente il bosco è distante dal pensiero del “cittadino”, non gli appartiene e difficilmente è accettabile, addirittura non pensabile come “unità strutturale” in ambiente periurbano.
Solitamente, il bosco è il luogo delle vacanze estive, delle passeggiate lungo i sentieri ben segnati dai quali guardiamo il bosco a distanza, forse perché di fatto non abbiamo il coraggio ad entrarvi in contatto perché suscita paura.
Pertanto la progettazione e la costruzione di fasce boscate periurbane necessitano, preliminarmente, di quattro condizioni, tutte di natura culturale, condizioni che sono imprescindibili affinché l’intervento possa attuarsi e durare nel tempo:
- La prima condizione: riguarda il coinvolgimento della Pubblica Amministrazione che deve avere il coraggio di farsi carico della scelta di realizzare le fasce boscate periurbane, in quanto l’intervento deve essere prima di tutto di natura pubblica.
Quando affermiamo che ci vuole coraggio ci riferiamo al “coraggio culturale”, perché l’unico rischio che la Pubblica Amministrazione può correre realizzando le fasce boscate periurbane è quello di migliorare l’ambiente circostante la città. Ma non sarà solo la città che ne trarrà beneficio! È arrivato il momento storico del fare con interventi strutturali, mentre purtroppo, troppe volte, si ascoltano solo slogan.
Si fa a gara per vedere chi la spara più grossa: “Pianteremo 4.500.000 (quattro milioni cinquecentomila) piante!” Qualche altro alza il tiro: “Pianteremo 60.000.000 (sessanta milioni) di piante”. Nessuno però che sappia dire dove verranno piantati gli alberi, ma soprattutto quando saranno piantati, come saranno accuditi nelle fasi iniziali di attecchimento e di crescita, come saranno difesi; piccoli dettagli di non poco conto! Rischiano di essere slogan privi di progettualità. Slogan oltre tutto pericolosi quando vengono lanciati da chi propugna il taglio degli alberi adulti esistenti per bruciarli nelle centrali elettriche a biomasse, dicendo che “tanto ne piantiamo di nuovi”.
- La seconda condizione: si riferisce all’interazione tra pubblica amministrazione e cittadinanza/opinione pubblica. Infatti, le scelte di chi amministra una città sono condizionate dalle richieste che un’opinione pubblica ben informata (noi cittadini) riesce a esprimere. Affinché la richiesta sia accolta, deve essere manifestata a piena voce e soprattutto deve essere corale. Se manca la coralità il progetto di fasce boscate periurbane rimane il pensiero/desiderio di pochi. Ma è pur vero che un progetto prima che diventi tale va sognato.
- La terza condizione: prevede che l’opinione pubblica sia in grado di formulare una richiesta articolata e motivata. Qui l’ingranaggio si blocca, perché spesso l’opinione pubblica non ha avuto modo di informarsi a sufficienza. Purtroppo, è noto che l’uomo ha paura del bosco e ciò è dovuto a un’intensa dose di pregiudizi/disinformazioni che sono duri a morire. È una paura che parte da molto lontano, ma che non porta da nessuna parte! Può essere l’occasione interessante per un nuovo processo selvi- culturale, per una cultura del bosco che deve riguardare primariamente gli esperti del settore e poi tutti noi cittadini non esperti ma che dal bosco traiamo benefici.
- La quarta condizione: riguarda la conoscenza che è necessaria per fare scelte coraggiose!
Occorre un impegno notevole per informarsi, per documentarsi; tutto ciò diventa più facile se siamo curiosi, perché è dalla curiosità che nasce la voglia di capire. Può essere la stessa Pubblica Amministrazione che ha a cuore il bene comune a incaricarsi di fare formazione/cultura affinché il buon cittadino sia in grado di fare scelte e richieste motivate.
I dati elaborati dall’ISPRA sul consumo di suolo nel nostro Paese sono impressionanti e il mondo della scienza fa appello perché si arresti la tendenza a peggiorare la situazione esistente. È ormai tempo di porre termine alle espansioni urbanistiche delle città, delle periferie, dei centri commerciali, delle aree industriali, delle aree artigianali. Queste coperture artificiali della terra impediscono la depurazione naturale delle acque, la ricarica delle falde idriche, e per contro nel corso delle piogge si verificano sovraccarichi dei sistemi fognari e la crisi delle capacità ricettive dei depuratori cittadini.
- PER MEGLIO QUALIFICARE IL PROGETTO: I CONTENUTI STRUTTURALI E FUNZIONALI
La realizzazione delle fasce boscate periurbane possono generare effetti benefici così sinteticamente elencati:
- sulla salubrità dell’aria;
- sulla regolazione del ciclo dell’acqua;
- sul microclima;
- sulla salute psichica e sulla salute fisica;
- sulla socialità in genere;
- sul miglioramento estetico e funzionale della periferia;
- sulla bellezza del paesaggio;
- sulla difesa/promozione della biodiversità nella sua massima espressione (api comprese).
Le fasce boscate periurbane trovano un valido supporto e completamento anche dalla realizzazione dei “boschi ripariali” quelli lungo i corsi d’acqua. Per raggiungere questo obiettivo è importante e irrinunciabile la riappropriazione del demanio fluviale da parte della Pubblica Amministrazione Regionale in funzione della costituzione della copertura forestale negli ambiti circostanti ai corsi d’acqua tutto ciò in funzione:
- dell’aumento dei tempi di corrivazione[3] delle acque meteoriche;
- della formazione di fasce tampone che intercettano il materiale in sospensione che proviene dall’erosione superficiale dei terreni durante gli eventi meteorici di forte intensità;
- della stabilizzazione delle sponde fluviali da frane e dissesti;
- del ripristino delle “reti ecologiche[4]” naturali, e se progettati in ambito di bacino idrografico possono collegare paesi e città tra la sorgente e la foce;
- dell’incremento della biodiversità vegetale e animale: quest’ultima componente svolge un forte potere comunicativo esaltando la bellezza dell’ambiente naturale;
- dell’aumento delle capacità di autodepurazione naturale dei corsi d’acqua, in aderenza alle finalità della Direttiva Quadro sulle Acque (Dir. 60/2000/CE) e del Testo Unico in Materia Ambientale (D. Lgs 152/06)
- del restauro del paesaggio, in aderenza all’art. 9 della Costituzione.
Si sottolinea che la ricostituzione di adeguate fasce boscate tampone lungo i corsi d’acqua costituisce un provvedimento che richiede modesto impegno di risorse economiche e i cui risultati sono assai rapidi, nell’ordine di pochi anni, dal momento che la vegetazione delle aree umide è a velocissimo accrescimento.
È importante ribadire che le fasce boscate periurbane sono fortemente correlate con la salute dell’ambiente e la salubrità dell’aria e pertanto contribuiscono alla formazione di una buona socialità e, in particolare, nella periferia delle città che spesso è soggetta a degrado.
Gli interventi forestali fino ad ora proposti possono generare un interessante effetto positivo anche per l’economia, sia direttamente sia indirettamente risparmiando sulle spese sanitarie per merito di un ambiente più sano, e creando posti di lavoro. È l’unico caso in cui, incrementando il patrimonio vegetale, possiamo parlare di effettivo “sviluppo sostenibile” senza cadere in un ossimoro.
La realizzazione delle “fasce boscate periurbane” determinano posti di lavoro in diversi settori:
- per la realizzazione di vivai forestali per avere la materia prima per gli interventi di forestazione;
- per la raccolta dei semi provenienti da boschi da seme da utilizzare per i vivai forestali;
- per la realizzazione/formazione e la manutenzione dei vivai forestali;
- per la bonifica delle aree degradate e successivamente per intervenire con l’attività di forestazione;
- per gli interventi di manutenzione nei parchi urbani e sulle alberature stradali;
- per la realizzazione di corsi di formazione per vivaisti;
- per la realizzazione di corsi di formazione per manutentori delle aree verdi urbane in generale, ovviamente con una cultura nuova della manutenzione del verde nella città.
- per una diagnosi anche strumentale, scientificamente corretta, dello stato fitosanitario del patrimonio arboreo che eviti l’abbattimento ingiustificato di alberi sani che non costituiscono un pericolo.
- I TEMPI PER INTERVENIRE E LE MODALITA’ DI INTERVENTO
Questo nuovo processo di miglioramento di qualità della vita delle città e di mitigazione del nuovo clima caratterizzato, tra l’altro, da “isole di calore” responsabili di innumerevoli decessi prematuri, necessita di interventi di diversa natura:
- a livello giuridico con la revisione di alcune leggi nazionali/regionali e regolamenti comunali;
- modificando il “concetto di sicurezza” che costringe i Sindaci a fare capitozzare gli alberi in ambito urbano in quanto responsabili di eventuali cadute di piante;
- definendo la responsabilità dei pubblici amministratori,
- definendo la responsabilità dei cittadini nei confronti di ambienti naturali, semi naturali e urbani in particolare per quanto riguarda i parchi o i singoli alberi.
Siamo consapevoli che, per ciò che abbiamo scritto in premessa, i progetti necessitano di tempi lunghi per la loro realizzazione, ma purtroppo in questo contesto storico occorre abbreviare i tempi di intervento; è inammissibile pensare a un “periodo di interventi sperimentali” come è raccontato/riportato nel Decreto-legge n. 111[5] del 14 ottobre 2019, e che solo dopo la sperimentazione si potrà dare seguito a eventuali interventi strutturali. Le scienze forestali nel nostro Paese sono mature e beneficiano di decenni di ricerche e di sperimentazioni che ci consentono di agire da subito nel restauro ambientale.
È necessario che si passi dalla fase di sperimentazione alla fase di progettazione esecutiva che deve prevedere il coinvolgimento di tutto il territorio nazionale; ma siccome stiamo parlando alle amministrazioni locali chiediamo che esse intervengano sul processo in atto con progetti che incidano strutturalmente sul proprio territorio. È ovvio che ogni amministrazione locale deve fare la propria parte, con un progetto che deve riguardare tutto il territorio amministrato.
È necessario pertanto definire:
- dove collocare le fasce boscate periurbane: è condizione necessaria e irrinunciabile localizzare in modo puntuale, su cartografia di dettaglio, le aree da dedicare agli interventi per la realizzazione di fasce boscate periurbane;
- quando iniziare l’intervento di forestazione: è condizione necessaria e irrinunciabile stabilire i tempi di intervento, perché l’utilizzo delle piante è condizionato dalla loro ciclo biologico. Infatti, i tempi per l’intervento sono ben precisi e prudenzialmente si indicano da novembre a marzo durante la fase del fermo vegetativo.
- quale materiale utilizzare: è condizione necessaria e irrinunciabile utilizzare materiale vegetale (erbaceo, arbustivo, arboreo) tipico del territorio di intervento, della vegetazione potenziale spontanea del luogo e prelevato quanto più vicino possibile al luogo dell’operazione e pertanto è necessario pensare a costituire per tempo vivai forestali.
Ciò richiede l’implementazione delle quattro fasi descritte nella parte iniziale, con il sostegno attivo della pubblica opinione che divenga subito parte attiva nel chiedere questi interventi strutturali. Purtroppo i processi culturali hanno di solito tempi molto lunghi, pertanto anche in assenza di stimoli dal basso è necessario che la pubblica prenda l’iniziativa svolgendo un ruolo di promozione culturale.
Le iniziative della pubblica amministrazione per sviluppare fasce boscate periurbane e il processo formativo/culturale dell’opinione pubblica devono partire fin da oggi e camminare in parallelo affinché i risultati siano concreti e soprattutto duraturi.
[1] L’ExtraTerrestre supplemento a “Il Manifesto”, 2 dicembre 2019, pp.72-73
[2] Ecosistema = L’ecosistema è l’unità ecologica fondamentale, formata da una comunità di organismi viventi in una determinata area (biocenosi) e dallo specifico ambiente fisico (biotopo), con il quale gli organismi sono legati da complesse interazioni e scambi di energia e di materia. Un ecosistema comprende diversi habitat e differenti nicchie ecologiche. L’habitat è il luogo fisico dove un animale o una pianta vivono normalmente, in genere caratterizzato da una forma vegetale o da un aspetto fisico dominante (per esempio, un corso d’acqua o una foresta). La nicchia ecologica è il ruolo ecologico, o “funzione”, che ogni specie occupa all’interno di un habitat, cioè è uno spazio che include tutti gli aspetti dell’esistenza di quella specie. Per esempio, una nicchia ecologica è definita dalle esigenze alimentari, dalle abitudini di vita e dalle interazioni della specie considerata con altre specie, oltre che dalle condizioni climatiche e chimico-fisiche. La nicchia ecologica è unica per ogni specie.
Tratto da: http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/biologia/Organismi-e-ambiente/Fondamenti-di-ecologia/L-ecosistema.html (Ultima ricerca il 12/12/2019)
[3] Tempo di corrivazione = è il tempo che impiega la pioggia, cadendo a terra, per raggiungere il corso d’acqua più vicino.
[4] Malcevschi S., Bisogni L.C., Gariboldi A., 1996 – Reti ecologiche ed interventi di miglioramento ambientale. Il Verde Editoriale
[5] DECRETO-LEGGE 14 ottobre 2019, n. 111. Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
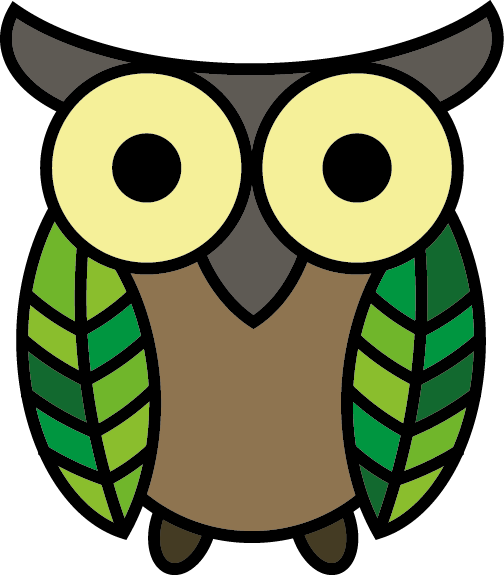







Commenti recenti